Chirurga non vaccinata chiusa in magazzino - L'AADOSS la fa ritornare in sala operatoria
- 29 ago 2022
- Tempo di lettura: 9 min
L’ufficio legale dell’Associazione Avvocatura Degli Infermieri (A.A.D.I.), che serve anche l’AADOSS cioè il Sindacato gemello creato per aiutare chi non è infermiere a far valere i propri diritti, soprattutto in questa era di fanatismo vaccinocratico, è intervenuto per assistere una chirurga di Siena, al termine della sua lunga carriera, che era stata relegata in un magazzino, con tanto di scatoloni e via vai di operatori che entravano ripetutamente per prelevare i kit contenuti nei contenitori, strappata dalla sala operatoria perché non vaccinata.
La disposizione emarginativa dell’azienda aveva previsto lo svolgimento di alcune attività amministrative mediche, ma, in verità, la chirurga è stata chiusa in magazzino e lasciata appassire davanti un catasto di scatoloni senza fare nulla.
Nonostante il medico competente avesse ravvisato l’idoneità allo svolgimento della mansione di Dirigente Medico nel Reparto Chirurgia Generale dell’ospedale, per i suoi superiori, la dottoressa andava isolata come una lebbrosa.
I motivi di diritto eccepiti dall’AADOSS hanno riguardato la corretta interpretazione dell’art. 4, co. 2 del D.L. 1° aprile 2021 n. 44 e precisamente che gli esonerati possono essere adibiti a mansioni “anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2”.
Pur eccependo l’illogicità e l’eccessività di tale norma, considerato che la dottoressa è immunizzata contro il Covid-19, se non meglio dei vaccinati, è oramai scientificamente e incontestabilmente consolidato che anche i vaccinati infettano esattamente come i non vaccinati e che i vaccinati, maggiormente protetti dal vaccino rispetto ai non vaccinati, rischierebbero meno la vita in caso di infezione rispetto ai non vaccinati (per cui non si comprende per quale motivo sarebbe la ricorrente non vaccinata a diffondere il virus ponendo in pericolo i vaccinati anche se sono superprotetti e che, quindi, è la ricorrente che dovrebbe essere protetta dai vaccinati e non viceversa), quello che qui rileva è la locuzione legislativa utilizzata al co. 7 e cioè che gli esonerati possono anche essere assegnati a mansioni diverse, non che lo debbano esserlo per forza.
Quindi, giustamente, il medico competente ha espresso un giudizio sulla compatibilità delle mansioni di chirurgo optando per la piena idoneità; idoneità che, si badi bene, non è stata contestata dal datore di lavoro che avrebbe potuto inviare, ex art. 3, D.P.R. 27 luglio 2011 n. 171, la ricorrente alla Commissione Medica Superiore oppure ricorrere allo SPRESAL avverso il giudizio (servizio di medicina del lavoro superiore a quello aziendale), ex art. 41, co. 9, D.Lgs. n. 81/2008.
Naturalmente, la dottoressa, indosserà tutti i dispositivi di sicurezza idonei ad evitare la diffusione da SARS-CoV-2, esattamente come i colleghi vaccinati che infettano e si ammalano come i non vaccinati (se non di più).
Il giudizio del medico competente è un parere vincolante per il datore di lavoro perché deve essere letto in chiave tecnica ai fini dell’applicazione dell’art. 2087 C.C. e, quindi, in funzione della tutela della salute del dipendente.
La giurisprudenza ha stabilito che: “Il medico competente è titolare di una propria sfera di competenza, si tratta di un garante a titolo originario e non derivato. E peraltro, l’obbligo di collaborazione con il datore di lavoro da parte del medico competente, il cui inadempimento integra il reato di cui agli artt. 25, comma primo, lett. a) e 58, comma primo, lett. c), del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, comporta un’effettiva integrazione nel contesto aziendale del sanitario, il quale non deve limitarsi a un ruolo meramente passivo, ma deve dedicarsi a un’attività propositiva e informativa in relazione al proprio ambito professionale” – Cass. IV Pen., 1° giugno 2021 n. 21521; III Pen., 9 agosto 2018 n. 38402.
Nel caso di specie, il medico competente, aveva espresso un giudizio che non ravvisava alcuna limitazione nei riguardi della dottoressa e, quindi, confermava la piena potenzialità professionale che la dipendente avrebbe potuto spendere a favore dell’azienda, riacquistando le proprie energie professionali e lavorative anche per conseguire il benessere personale, inteso come estrinsecazione della propria personalità sul luogo di lavoro, esattamente come prevede l’art. 2 Cost. e la giurisprudenza in materia affinché “non si comprometta la professionalità raggiunta” - Cass. Lav., 3 marzo 2016 n. 4211.
Nel pubblico impiego privatizzato non si applica, per la disciplina delle mansioni, l’art. 2103 C.C., ma l’art. 52 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 (Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti nell’ambito dell’area di inquadramento ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per effetto delle procedure selettive), con la differenza che, nel primo caso, si parla di equivalenza sostanziale delle mansioni, mentre nel secondo di equivalenza formale.
Unitamente all’art. 52 succitato, concorre per la disciplina delle mansioni, l’art. 16 del D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3 (L’impiegato deve eseguire gli ordini che gli siano impartiti dal superiore gerarchico relativamente alle proprie funzioni o mansioni) e l’art. 52, co. 1 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165,
Sulla base degli artt. 2 e 41 della nostra Carta Costituzionale, la dottrina e la giurisprudenza hanno costruito il senso del valore che rappresenta la professionalità e l’esercizio della propria attività nell’ambiente lavorativo, inteso come luogo nel quale di esplica la propria personalità, diritto fondamentale dell’individuo.
Tutto ciò si traduce in una protezione e salvaguardia della professionalità, come tutelata dal nostro ordinamento, acquisita nel tempo come patrimonio del lavoratore che riverbera a vantaggio del datore di lavoro che si arricchisce delle competenze e dell’esperienza del prestatore di lavoro.
La lesione alla professionalità non si traduce solo nel demansionamento, ma anche nell’inattività.
L’azienda, ignorando il giudizio della medicina del lavoro, si è arrogata il potere, privo di titolarità, di comprimere la professionalità della ricorrente, sulla base di asserzioni del tutto apodittiche e pregiudizievoli, perché non solo ha distrutto la funzione chirurgica immanente la professione della ricorrente, assegnandole, sulla carta, mansioni amministrative che nella pratica medica sono corollario della pratica chirurgica, diagnostica e terapeutica propria del medico (c.d. mansioni accessorie e strumentali), ma, di fatto, l’ha lasciata chiusa in un magazzino, mortificandola, senza fare niente!
Le mansioni amministrative che le avevano assegnato non sono mai state svolte!
Atteso che la verifica del Giudice deve essere orientata a stabilire se le mansioni assegnate alla ricorrente siano state nel tempo congrue ed anzi, tese allo sviluppo, al miglioramento e al raffinamento delle competenze acquisite nel pregresso, affinché la personalità della lavoratrice possa essersi manifestata e realizzata efficacemente anche sul piano lavorativo, la giurisprudenza sul punto è chiara: “Sussiste il diritto del lavoratore all’effettivo svolgimento della propria prestazione professionale la cui lesione da parte del datore di lavoro costituisce inadempimento contrattuale e determina, oltre all’obbligo di corrispondere le retribuzioni dovute, anche l’obbligo di sanare i danni subiti, che possono assumere aspetti diversi in quanto possono consistere non solo nel danno patrimoniale derivante dall’impoverimento della capacità professionale acquisita dal lavoratore e dalla mancata acquisizione di una maggiore capacità o nel pregiudizio subito per perdita di chance ossia di ulteriori possibilità di guadagno, ma anche in una lesione del diritto del lavoratore alla integrità fisica o, più in generale, alla salute ovvero alla immagine o alla vita di relazione (per tutte, Cass., 14 novembre 2001 n. 14199). Più in particolare ancora, occorre ribadire che la negazione o l’impedimento allo svolgimento delle mansioni, al pari del demansionamento professionale, ridondano in lesione del diritto fondamentale alla libera esplicazione della personalità del lavoratore anche nel luogo di lavoro, determinando un pregiudizio che incide sulla vita professionale e di relazione dell’interessato, con una indubbia dimensione patrimoniale che rende il pregiudizio medesimo suscettibile di risarcimento e di valutazione anche in via equitativa” – Cass. Lav., 22 marzo 2016 n. 5577; 22 febbraio 2003 n. 2763 e 02 gennaio 2002 n. 10.
“Costituisce, invero, principio ormai acquisito che possano legittimamente assegnarsi al dipendente, a parità d’inquadramento, mansioni anche del tutto nuove e diverse, purché affini alle precedenti dal punto di vista del contenuto professionale. L’esistenza, per così dire, di un minimo comune denominatore di conoscenze teoriche e capacità pratiche è condizione necessaria e sufficiente a consentire che il dipendente sia in grado di svolgere le nuove mansioni con la preparazione posseduta. Anzi, questa Corte ha affermato che se è vero che le ulteriori nuove mansioni affidate al dipendente debbano essere coerenti con la specifica competenza da lui maturata, ciò non deve disperdere del tutto il patrimonio professionale e di esperienza già maturato, compromettendo altresì irrimediabilmente le sue prospettive di carriera, tale da comportare un abbassamento del globale livello delle prestazioni del lavoratore con sottoutilizzazione delle capacità dallo stesso acquisite ed un consequenziale impoverimento della sua professionalità posto che il lavoro costituisce non solo un mezzo di guadagno, ma anche un modo di estrinsecazione della personalità del lavoratore” - Cass. Lav., nn. 17774/2006; 10091/2006; 4975 del 8 marzo 2006; 3046 del 13 febbraio 2006; 425 del 12 gennaio 2006; 14496 del 11 luglio 2005; 11045 del 10 giugno 2004; 5651 del 20 marzo 2004; 2649 dell’11 febbraio 2004; 6714 del 2 maggio 2003; 2763 del 22 febbraio 2003; 2328/2003; 10 del 2 gennaio 2002; 10284 del 4 agosto 2001; 7821 dell’8 giugno 2001 e la 7789/93.
Nella fattispecie, comunque, va operata una distinzione tra demansionamento e inattività; la giurisprudenza si regola in maniera diversa e in ambito dell’inattività è più drastica.
Tralasciando la ricca esegesi e la giurisprudenza sul punto, si è pure affrontato il tema della violazione dell’art. 2087 C.C. e della prudenza in generale.
La norma da applicarsi al caso di specie e che tutela la salute sul posto di lavoro è fornita, principalmente, dall’art. 2087 C.C. che recita: “L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio della impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”.
L’articolo in questione trova la sua genesi nei più importanti principi costituzionali quali la tutela del lavoro in tutte le sue forme e applicazioni (art. 35), il riconoscimento della tutela della salute come diritto dell’individuo (autonomo diritto, primario, assoluto, risarcibile) e fondamentale interesse della società (art. 32) e il vincolo insuperabile per l’iniziativa economica privata, che è libera, ma “non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana” (art. 41, c. 2).
Siffatta garanzia integra allora, secondo contributi ed evoluzioni dottrinali, un obbligo c.d. “autonomo” di protezione il che, quindi, consentirebbe di isolare il dovere del datore di lavoro di adottare misure specifiche finalizzate a realizzare condizioni di tutela dello svolgimento dell’attività lavorativa nell’impresa, cosicché la persona del dipendente è salvaguardata al di là e indipendentemente dall’esecuzione dei singoli segmenti di prestazione - Cass. Lav., 4 ottobre 2019 n. 24883.
Da tale prospettazione deriva, evidentemente, che tale obbligo di protezione è ascritto al datore di lavoro attesa la sua condizione di titolarità del potere organizzativo generale dell’impresa.
Secondo quanto prescritto dall’art. 1176 C.C., il datore di lavoro deve comportarsi con la diligenza necessaria, così espressa: “Nell’adempimento dell’obbligo inerente all’esercizio di un’attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell’attività esercitata”.
Al datore di lavoro viene richiesta una particolare accuratezza sia nell’individuazione dei fattori di pericolo, sia nella scelta delle misure di prevenzione necessarie a tutelare l’integrità fisica del lavoratore, anche se non specificamente previste da norme di prevenzione o da altre prescrizioni di organi competenti.
Il precetto amplia notevolmente il dovere di sicurezza del datore di lavoro, in quanto tale dovere non è più fissato da regole precise e statiche che inevitabilmente col tempo verrebbero superate (Corte costituzionale, 18 luglio 1996 n. 312).
Come sottolinea anche Cass. Sez. Pen. 09.03.1992, n. 2835, “L’obbligo di tutela delle condizioni di lavoro si estende anche alla fase dinamica dell’espletamento del lavoro ed ai comportamenti necessari per prevenire possibili incidenti, in ogni posto e fase di lavoro” - Così pure Cass. Lav., 06.09.1995, n. 9401; n. 3740/1995; n. 10361 del 21.10.1997; Sezione IV, 03.10.2007 n. 44791 e Cass. Sez. Pen. 15.07.1988.
L’art. 2087 C.C. “non contiene soltanto l’enunciazione di un dovere imposto nell’interesse generale, ma sancisce una vera e propria obbligazione, imponendo all’imprenditore una serie di misure che si risolvono in una prestazione, che egli è tenuto ad adempiere e che il lavoratore ha diritto di pretendere. Tale disciplina concerne perciò l’organizzazione del lavoro nell’impresa e reca un principio di autoresponsabilità dell’imprenditore, il quale, indipendentemente da specifiche disposizioni normative, è tenuto a porre in essere tutti gli accorgimenti e le misure necessarie ad evitare il verificarsi di lesioni della salute e dell’integrità fisica del lavoratore” - Cass. Lav., 6 novembre 2018 n. 28244, così graniticamente da sempre: Cass. Lav., 29 gennaio 1970 n. 199, 13 luglio 1971 n. 2287, 12 gennaio 1973 n. 104, 11 ottobre 1979 n. 5315, 16 aprile 1986 n. 2692, 23 giugno 1986 n. 4171, 7 marzo 1987 n. 2417, 7 aprile 1988 n. 2737, 6 settembre 1988 n. 5048, 29 maggio 1990 n. 5002, 26 gennaio 1993 n. 937, 8 febbraio 1993 n. 1523; 5 aprile 1993 n. 4085; 17 novembre 1993 n. 11351; 1° febbraio 1995 n. 1168 e 6 settembre 1995 n. 9401; Cass. sez. III, 18 novembre 1976 n. 4318; 06 settembre 1988 n. 5048.
Soccorre, quindi, la generale norma di chiusura di cui all’art. 2087 C.C., la quale impone l’obbligo al datore di lavoro, anche in assenza di specifiche prescrizioni (quali quelle di cui al D.P.R. n. 547 del 1955), di adottare tutte le misure necessarie a tutelare l’integrità fisica del lavoratore e dunque le generiche misure di diligenza e prudenza ed osservanza delle norme tecniche e di esperienza la cui applicazione, secondo una valutazione ex ante resa dall’homo eiusdem conditionis et professionis, appaia in grado di scongiurare fatti dannosi per il prestatore nell’ambiente di lavoro.
Si è trattato anche il tema sulla Prova, sulla Inversio probandi, sul Procedimento presuntivo semplice, il Nesso causale, il Diritto ad un ambiente sano, i Canoni ermeneutici e principi ex artt. 1175 e 1375 C.C., l’Abuso ex art. 96 C.P.C., i Danni patrimoniali, la Professionalità, la Chance, la Carriera e la Discriminazione, spendendo, in ricorso, ben 27 pagine di sostenuta logica giuridica di alto livello argomentativo che, il Tribunale del Lavoro di Pisa, con Ordinanza cautelare del 20 agosto 2022 n. 382-1, ha praticamente accolto totalmente in 24 pagine che verranno esaminate nel prossimo articolo.




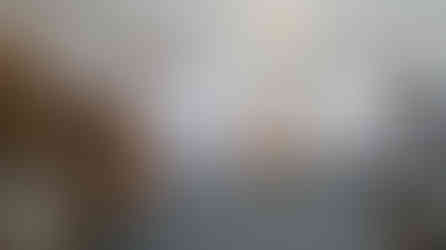








Commenti